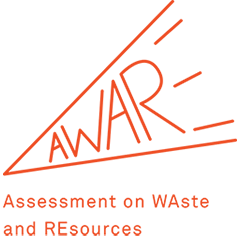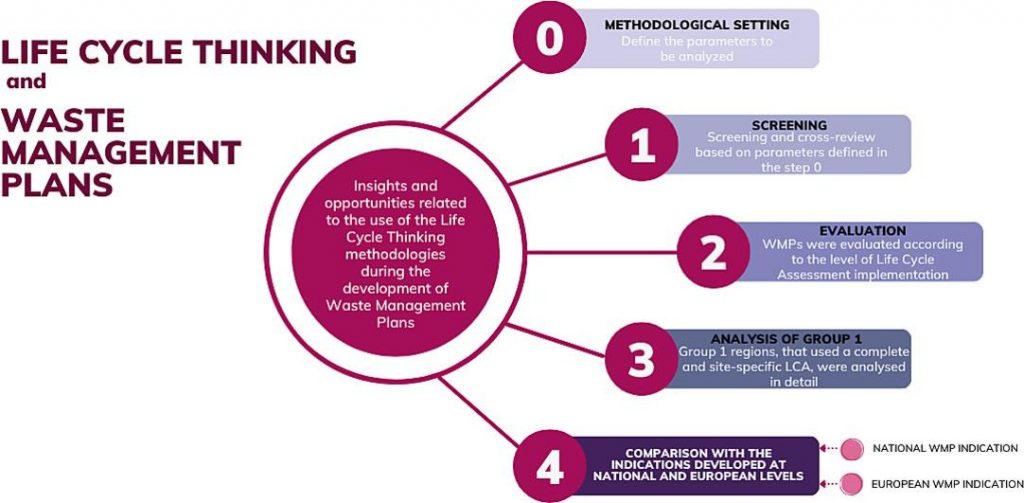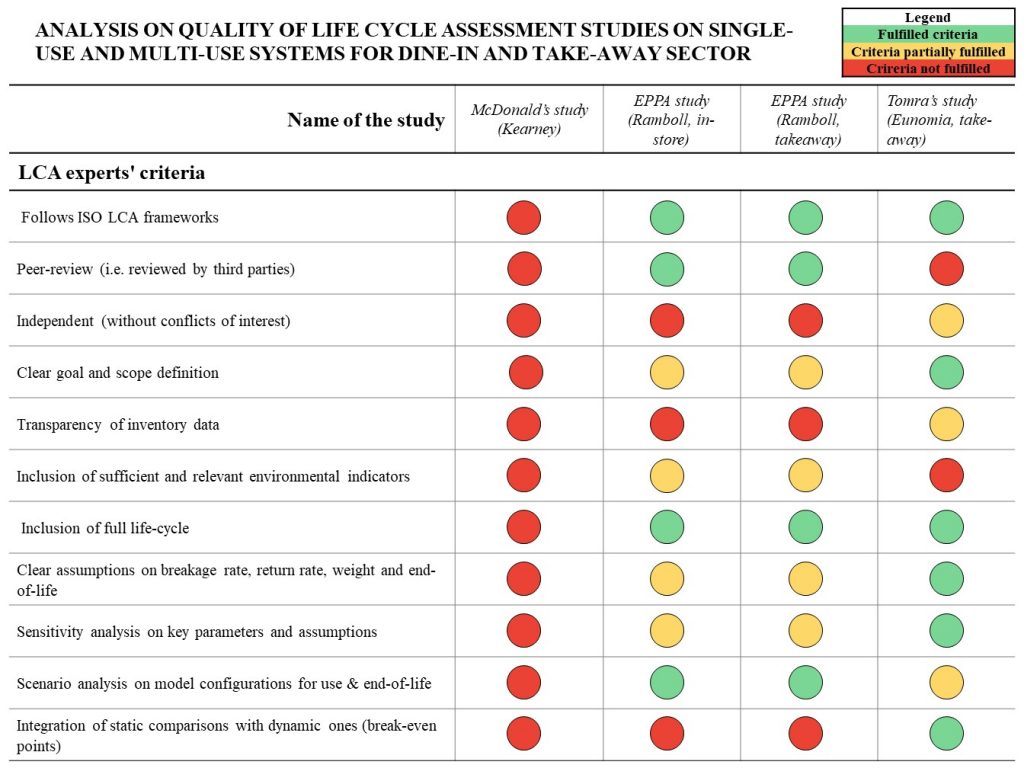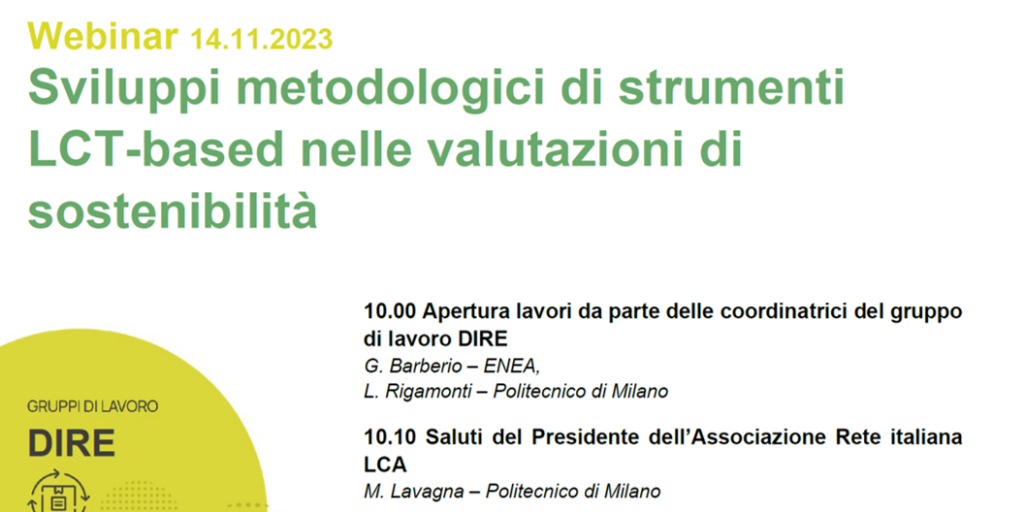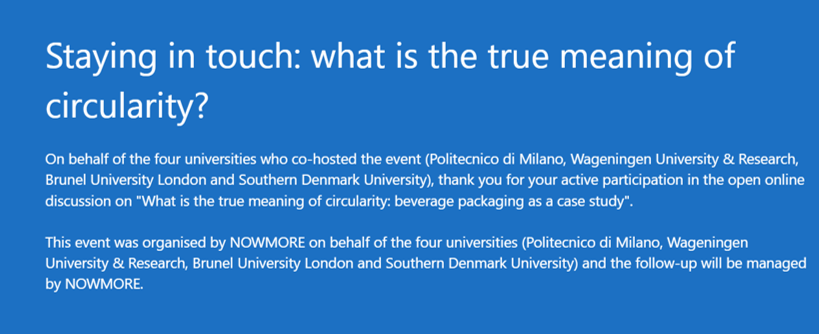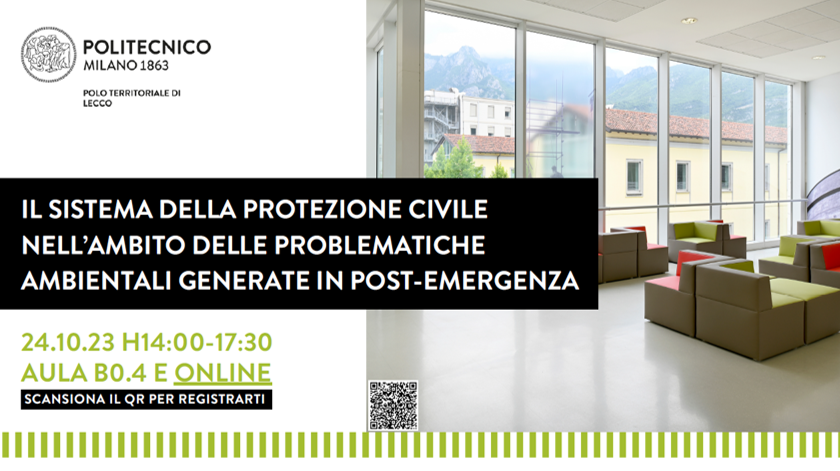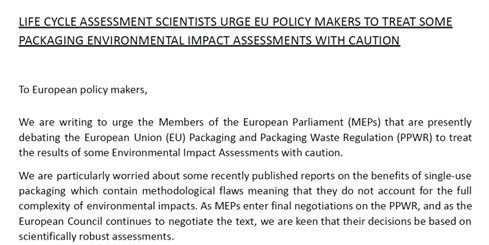Nel contesto delle attività di economia circolare e prevenzione dei rifiuti, il mio lavoro di tesi ha analizzato se e in che misura l’attività del centro del riuso “Panta Rei” di Vimercate possa effettivamente contribuire a fornire benefici ambientali. Tale valutazione è stata effettuata utilizzando la metodologia LCA, modellizzando la prima e la seconda vita dei beni in esame e distinguendo tra impatti ambientali evitati (prima vita) e impatti aggiuntivi (seconda vita). I risultati hanno mostrato che nel 2022 il centro ha generato benefici ambientali in solo 6 delle 16 categorie di impatto esaminate. La prestazione ambientale dell’attività di riuso, infatti, dipende da numerosi fattori, quali il tasso di sostituzione (indica se l’acquisto di un bene usato sostituisce realmente l’acquisto di un bene nuovo), il tasso di qualità (indica la vita media attesa del bene usato rispetto a quella del bene nuovo), l’indice di prestazione energetica (indica la prestazione energetica del bene usato rispetto a quella del bene nuovo), la distanza tra centro del riuso e abitazione del secondo utente e il tempo effettivo di utilizzo del bene. Una sostituzione del 100% tra beni nuovi e usati, ad esempio, porterebbe a benefici ambientali in tutte le categorie di impatto. Sono state così identificate tre azioni chiave per migliorare le prestazioni ambientali dei centri del riuso: aumentare la consapevolezza dei cittadini sugli impatti delle loro azioni, promuovere la mobilità sostenibile e ridurre le distanze tra centro e consumatori. Il lavoro sottolinea, in definitiva, l’importanza del ruolo del consumatore nel garantire benefici ambientali nelle attività di prevenzione dei rifiuti. Mary Jo Floriana Antonia Nichilo
Lo studio svolto nella mia tesi parte da un’indagine effettuata sul territorio calabrese, nella provincia di Catanzaro, ove risulta frequente il fenomeno dell’abbandono massiccio di rifiuti. L’obiettivo dello studio è stato analizzare l’impatto ambientale della gestione dei suddetti rifiuti tramite la metodologia LCA. A causa della loro qualità compromessa dall’azione degli agenti atmosferici, il riciclo di materiali viene escluso, ma ne viene considerato il recupero energetico. Sono stati individuati tre scenari: lo smaltimento in discarica, la gestione tramite termovalorizzatore e la gestione tramite gassificatore. I risultati hanno mostrato come la gestione tramite gassificatore ha un impatto irrilevante (a tratti negativo) sulle categorie di tossicità, mentre dal punto di vista delle emissioni atmosferiche è nettamente in svantaggio rispetto il termovalorizzatore. Perciò per la gestione immediata di tali rifiuti è consigliato il trattamento tramite termovalorizzatore. Tuttavia, la gestione tramite gassificatore lascia degli interessanti spunti di lavoro per la riduzione delle emissioni, al fine di renderlo comparabile e competitivo rispetto al termovalorizzatore in termini di impatto ambientale. Sara Mattei
In today’s world, there is an urgent need to shift towards sustainable fuel and energy options, and these alternatives to consider need to be environmentally friendly, throughout their life cycle. Hydrogen emerges as a promising option due to its lack of Carbon dioxide emissions, high-energy content, and favourable combustion kinetics. The Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) in Leipzig, Germany, has developed a white hydrogen production technology utilizing cyanobacteria, that could contribute to global sustainable energy demands. This study conducts a comprehensive Life Cycle Assessment of this white hydrogen production technology, intending to elucidate its environmental consequences and potential as a sustainable energy solution. Results show that this technology is an energy-intensive process and relies significantly on electricity, and the impact on the environment is exacerbated by the German electricity mix to levels comparable to conventional grey hydrogen production technologies. Shifting to renewable energy sources, especially wind, reduces environmental impacts by 75%, but challenges persist. This study advocates a holistic approach, combining renewable energy sources and sustainable choices of BG-11 medium to substantially diminish environmental impacts. Despite challenges, hydrogen production by cyanobacteria remains a promising avenue for sustainable hydrogen production, aligning with the global pursuit of greener energy alternatives. Usamah Derwaish