Convertire l’anidride carbonica dalla produzione di acciaio in metanolo per alimentare il trasporto marino: ora si può!
Il progetto FreSMe ha raggiunto il suo obiettivo: leggi qua per una descrizione del progetto e dei risultati ottenuti

Gli oli lubrificanti usati sono rifiuti pericolosi che possono causare seri problemi all’ambiente e salute pubblica se non gestiti adeguatamente. I Paesi sottosviluppati sono i più vulnerabili alle conseguenze ambientali di gestione inefficiente di tali rifiuti persistenti. Un buon punto di partenza per comprendere i sistemi di gestione dell’olio usato in tali Paesi è attraverso le ONG umanitarie che operano là. In collaborazione con il comitato internazionale della croce rossa (CICR), questo caso di studio sulla gestione degli oli usati in Kenya, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo è stato condotto per comprendere i potenziali impatti ambientali degli attuali sistemi di gestione degli oli usati nel contesto umanitario del CICR e per esplorare le possibili azioni per ridurre questi impatti. La valutazione viene effettuata con la metodologia Life Cycle Assessment (LCA) seguendo il metodo di valutazione dell’impatto ReCiPe 2016. Due modelli LCA sono stati costruiti. Il primo rappresenta il Sud Sudan e la RDC. Inizia con la fase di stoccaggio e movimentazione, seguita dal trasporto ai cantieri. Nei cantieri, l’olio usato è applicato su legname per prevenire gli attacchi di termiti. Il secondo modello rappresenta il Kenya. Inizia con le fasi di stoccaggio e movimentazione, quindi l’olio esausto viene trasportato in una raffineria a Nairobi per recuperare l’olio base. I principali impatti del primo modello erano associati alla fase di trattamento antitermite che aveva impatti diretti sulle categorie di impatto della tossicità. Il secondo modello ha mostrato una completa dominanza della raffineria in tutte le categorie di impatto. Il principale contributo all’impatto aggiunto della raffineria è la produzione di argilla sbiancante attivata, che viene utilizzata nella fase di finitura della ri-raffinazione dell’olio usato. Confrontando i due sistemi a livello midpoint, è stato riscontrato che il sistema del Sud Sudan e della RDC ha prestazioni migliori in 11 categorie di impatto su 18. A livello endpoint, il Kenya ha mostrato prestazioni complessive migliori. Il limite principale di questo studio è la carenza di dati in alcuni punti, che ha implicato molte ipotesi e di conseguenza molte incertezze. Tuttavia, questo è prevedibile dato che si tratta del primo studio di questo tipo nel contesto dell’Africa orientale. Questa limitazione dovrebbe essere affrontata in un futuro lavoro acquisendo più dati rappresentativi del sistema per migliorare i modelli e la robustezza dei risultati, in particolare negli hotspots ambientali rilevati in questo studio, come la raffineria e la produzione di argilla sbiancante attivata.
Hazem Eltohamy

The main objective of my study was to conduct a review of selected computational water footprint (WF) methods by indicating their strengths and drawbacks, to provide some recommendations for application-dependent use of methods in LCA-based WF studies.Adopting the inside-out perspective, a total of 15 pre-selected WF methods were reviewed under three main groups i.e., 9 water depletion methods, 3 future efforts methods and 3 thermodynamic accounting methods, based on the underlying impact mechanisms and the water use issues addressed. The reviewed WF methods were thereafter summarized in a tabular format by considering their fundamental elements. Following an explicitly stated criteria, five (5) midpoint methods that only assess the impact category of water scarcity, and that are already available to be used in LCA software (SimaPro) were selected for case study application. The beneficiation process of Manganese ores available in the ecoinvent module was selected as a case study to better understand the environmental impacts of water use. Due to the strong dependence of WF from water consumption patterns and climate at local level, the spatial resolution of the 5 midpoint WF methods was tested by assuming two different locations, one in Africa (Gabon) and one in Europe (Poland). Sensitivity analyses were performed using 3 different calculation set ups to evaluate the reliability of results. All the 5 WF impact assessment methods showed that WF was higher in Poland than Gabon, and both country-specific WF results were lower than the global reference set up. The results from the WF analysis of the case study were then used to make conclusions and recommendations for future developments and research.
Emmanuel Nyero

A fronte del costante aumento della quantità di bioplastiche compostabili conferita con il rifiuto organico e della recente tendenza a preferire il trattamento anaerobico in luogo di quello aerobico, è di fondamentale importanza valutare la compatibilità delle bioplastiche con il trattamento di digestione anaerobica. Nel mio lavoro di tesi ho studiato la degradazione anaerobica in condizioni termofile di diversi sacchetti in bioplastica impiegati per la raccolta del rifiuto alimentare (sia shopper che dedicati), in comparazione con un sacchetto in carta alternativo. In particolare, la degradazione anaerobica dei sacchetti è stata studiata a mezzo di prove di biometanazione in batch (BMP – Biochemical Methane Potential) e prove di co-digestione con il rifiuto alimentare in condizioni di alimentazione semi-continua, per meglio simulare la gestione a scala reale. Inoltre, sono state eseguite prove di tipo fisico sui sacchetti in bioplastica analizzati nelle prove in semi-continuo, allo scopo di indagare il meccanismo degradativo delle bioplastiche, con particolare riguardo al contributo di fattori fisici. Nelle prove di BMP è stata osservata una buona degradabilità (>71%) dei sacchetti in bioplastica, mentre le prove in semi-continuo hanno mostrato una degradabilità molto ridotta (<27%), confermata dallo stato fisico dei pezzi di sacchetti non digeriti. Inoltre, è stato osservato un comportamento molto differente nelle prove in semi-continuo per diversi sacchetti in bioplastica, che è risultato almeno parzialmente attribuibile all’effetto di fattori fisici. Al contrario, prospettive molto interessanti sono offerte dal sacchetto in carta, la cui degradabilità anaerobica nelle prove in semi-continuo (82%) è risultata anche superiore a quella osservata nelle prove di BMP (74%).
Pertanto, il sacchetto in carta è più compatibile con il processo di digestione anaerobica rispetto ai sacchetti in bioplastica.
Valeria Venturelli

Il mio lavoro di tesi è nato dall’esigenza di definire e affrontare una tematica molto attuale come la diffusione delle bioplastiche sul mercato, proposte come alternativa più sostenibile alle plastiche fossili, sia come soluzione nella lotta contro il marine littering (Direttiva Single Use Plastic), sia nell’ambito dell’Economia Circolare. Ho quindi inizialmente analizzato le più importanti tipologie di bioplastiche, le biogeniche e biodegradabili, quelle fossili e biodegradabili e quelle biogeniche non biodegradabili, approfondendo di ciascuna vari aspetti, tra cui le caratteristiche del polimero, le tecniche di lavorazione, le applicazioni e le aziende produttrici. Ho presentato, in seguito, i risultati dell’analisi effettuata sul campo sulla presenza di prodotti in bioplastica in alcune delle più importanti catene della grande distribuzione organizzata in Italia. Si è potuto da lì notare che, nel settore del packaging, le bioplastiche sono ancora presenti in quantità esigue, sono poco distinguibili dalle rispettive controparti fossili e che alcune presentano dei limiti nelle condizioni di utilizzo. Successivamente, ho analizzato studi di letteratura riguardanti l’impatto delle bioplastiche negli impianti di riciclo della plastica e negli impianti di trattamento biologico. Inoltre, sono mostrati i risultati di studi effettuati sulla biodegradabilità delle bioplastiche compostabili in ambienti differenti: ambienti controllati aerobico e anaerobico, ambiente domestico e ambienti non controllati come acque dolci, mare e suolo. Da questi è emerso come le bioplastiche compostabili si degradino sufficientemente nei processi aerobici, ma che se trattate in condizioni anaerobiche o non controllate, mostrino serie difficoltà. La parte finale dell’elaborato è stata dedicata, invece, alla presentazione dei dati raccolti nei questionari che abbiamo sottoposto ad alcuni gestori degli impianti di trattamento rifiuti in Italia e dai quali sono state elaborate informazioni riguardo la quantità di bioplastica in ingresso ai rispettivi impianti e le azioni intraprese per la loro gestione. Con questo lavoro di tesi si è evidenziato come i processi biologici a cui vengono attualmente inviate le bioplastiche compostabili non siano adatti al loro trattamento perché non garantiscono alte temperature e tempi di residenza sufficientemente lunghi affinché questi biopolimeri compostabili riescano ad essere degradati correttamente. Così le bioplastiche da soluzione rischiano di diventare un problema, che deve esser opportunamente affrontato a livello di gestione complessiva.
Giulia Sora
Il 22-24 settembre 2021 si terrà il X Convegno dell’Associazione Rete Italiana LCA X con tematica “Innovazione e circolarità: il contributo del Life Cycle Thinking nel Green Deal per la neutralità climatica”.
In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che si pongono alla base delle politiche di ripresa post-Covid, il Green Deal europeo rappresenta la nuova roadmap della strategia di crescita sostenibile per raggiungere una giusta transizione energetica e la neutralità climatica entro il 2050 e attuare i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) di Agenda 2030, stimolando la creazione di valore e la resilienza dei sistemi economici.
E’ aperta la CALL FOR PAPERS: per maggiori informazioni si veda il sito del convegno
Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione del Convegno MatER, dal titolo “Recovery & Final Sinks for an Effective Waste Management”, che si terrà dal 7 al 9 giugno 2021 presso il campus di Piacenza del Politecnico di Milano. Il convegno si terrà in concomitenza con il “6° Convegno Internazionale sui Final Sinks”.
Il Convegno vuole essere un’occasione di aggiornamento sulle ultime tendenze rispetto al mondo dei rifiuti, sia per quanto riguarda gli aspetti strategici e normativi, che per quelli tecnologico-scientifici. La call for abstracts è indirizzata sia a contributi scientifici propri del mondo accademico e della ricerca che a contributi tecnici più di carattere industriale per gli operatori del settore. Le presentazioni orali e i poster verteranno su 6 argomenti principali: material recovery; innovative technologies; biowaste residual valorization; environmental sustainability; energy recovery; final sinks.
Per tutte le informazioni sul convegno MatER 2021: http://www.mater.polimi.it/mater-final-sinks-meeting-2021-home/
Clicca qui per la registrazione.
Clicca qui per la locandina dell’evento.
Clicca qui per il progamma preliminare.
Sulla rivista Frontiers in Climate sono stati pubblicati due studi svolti nell’ambito del progetto di ricerca Desarc-Maresanus nato dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano e la Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), con il supporto finanziario di Amundi e quello tecnico di CO2APPS.
Il primo studio analizza l’efficacia di rimozione della CO2 e del contrasto all’acidificazione nel bacino del Mar Mediterraneo mediante il processo di ocean liming, che consiste nello spargimento in mare di idrossido di calcio (calce idrata). Due scenari di spargimento sono stati valutati utilizzando un modello fisico-biogeochimico con i dati delle attuali rotte di navigazione. Il primo scenario è caratterizzato da un costante spargimento di idrossido di calcio in mare, complessivamente pari a 200 Mt all’anno, mentre il secondo scenario è contraddistinto da livelli di alcalinizzazione crescenti proporzionalmente alla riduzione del pH nello scenario di riferimento RCP 4.5. I risultati delle simulazioni modellistiche mostrano che dopo 30 anni di alcalinizzazione il tasso di assorbimento di CO2 del Mar Mediterraneo è quasi raddoppiato e la tendenza media all’acidificazione superficiale è neutralizzata rispetto allo scenario di riferimento senza alcalinizzazione. Maggiori informazioni sono disponibili nell’articolo al seguente link.
Nel secondo studio è stato stimato sia a livello globale sia a livello del bacino del Mar Mediterraneo il potenziale di spargimento di idrossido di calcio e la rimozione di CO2 in atmosfera sfruttando l’attuale traffico marittimo. È inoltre mostrato un alto potenziale di dispersione della calce in mare attraverso un modello fluidodinamico. L’articolo è disponibile al seguente link.
A cura di: Andrea Fedele e Lucia Rigamonti andrea.fedele@unipd.it, lucia.rigamonti@polimi.it, Gruppo di Lavoro “Gestione e trattamento rifiuti” Rete Italiana LCA.
Il giorno 9 marzo 2021 si è svolta la quinta edizione della giornata di studio “Rifiuti e Life Cycle Thinking – Per lo sviluppo di un’economia sostenibile”, edizione sviluppata interamente in modalità online con la trasmissione “live” tramite le piattaforme social e che ha visto un numero di iscritti pari a 450. L’evento, patrocinato dall’Associazione Rete Italiana LCA, è stato organizzato e coordinato dal gruppo di ricerca “AWARE” (Assessment on Waste and Resources) del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Gestione e Trattamento dei Rifiuti” dell’Associazione Rete Italiana LCA.
In linea con la ormai consolidata missione di questa iniziativa, la giornata di studio è stata un’ulteriore occasione per condividere aggiornamenti e sviluppi della ricerca scientifica sulla tematica della gestione sostenibile dei rifiuti e quella strettamente connessa dell’economia circolare. L’incontro è stato il momento per evidenziare l’importanza, specialmente in un momento storico come quello attuale, dove è forte il richiamo a concetti come “Green Deal” e “transizione ecologica”, di una gestione sostenibile dei rifiuti tramite l’approccio del ciclo di vita, a garanzia dell’implementazione di soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e anche sociale.
La giornata di studio è stata suddivisa in quattro sessioni, individuate considerando specifiche tematiche di ricerca su dettagliati topics e su diverse categorie di rifiuto: “Economia circolare: aspetti metodologici e applicazione nel campo industriale”, “Valorizzazione dei rifiuti nel settore delle costruzioni”, “Gestione e recupero di rifiuti urbani e industriali” e “Prevenzione e valorizzazione del rifiuto organico”. Se da un lato la prima sessione della giornata ha visto la condivisione di lavori di carattere generale sull’applicazione e lo stato dell’arte della ricerca del tema della valutazione della sostenibilità nel settore dei rifiuti, le seguenti sessioni hanno avuto focus specifici in considerazione alla gestione di differenti tipologie di rifiuto: da materiali e rifiuti da costruzione e demolizione, a rifiuti urbani e industriali (in particolare plastici), fino a rifiuti di tipo organico (ove interessanti risultano le analisi sul recupero di tali tipologie, nell’ottica dello sviluppo del concetto di circolarità).
Le riflessioni e le considerazioni finali hanno evidenziato ancora una volta le ampie possibilità di ricerca e di sviluppo relativamente la tematica dell’analisi di sostenibilità in questo vasto settore. Dal punto di vista metodologico occorre continuare il percorso di sviluppo e di utilizzo di metodiche condivise e validate dalla comunità scientifica per poter dare risultati il più possibile robusti e precisi. In questo senso il continuo sviluppo di metodi di caratterizzazione e di banche dati affidabili e complete sono e saranno due elementi fondamentali.
Arrivederci fra due anni, alla sesta edizione, con la speranza di poterci ritrovare in un’aula che non sia per forza virtuale!
Gli atti della 5a giornata di studio “Rifiuti e Life Cycle Thinking” sono disponibili qui.

In occasione della giornata mondiale dell’acqua oggi nasce BeviMI, una novità per una Milano più sostenibile! BeviMI sarà una APP, un gioco, ma anche una ricerca che coinvolgerà tre campus universitari della città nel prossimo Anno Accademico 2021-2022.
Bicocca, Politecnico e Statale collaboreranno insieme per sviluppare il progetto promosso da CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale Acqua. BeviMI è co-finanziato da Fondazione Cariplo e da Coripet, con il supporto tecnologico di Genuine Way.
AWARE si vedrà coinvolto nell’attività di ricerca, vi terremo aggiornati!
Qui trovate il comunicato stampa.
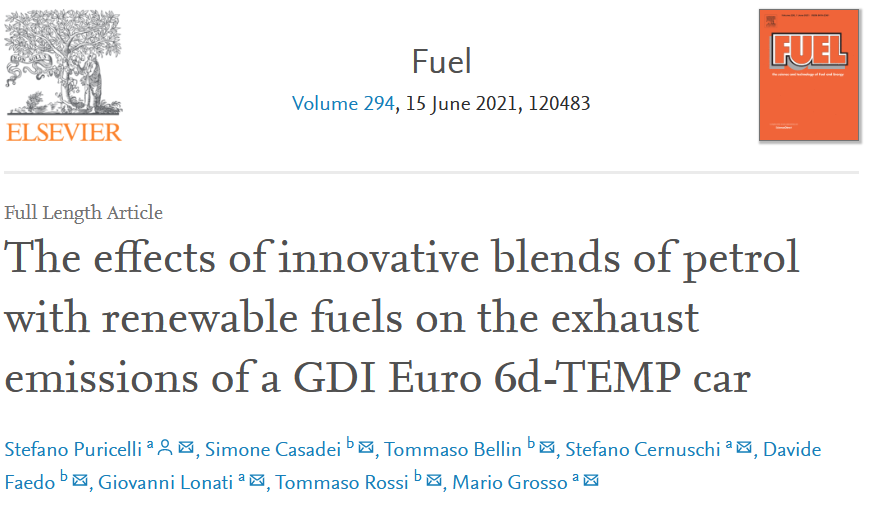
Sono stati pubblicati sulla rivista Fuel i risultati di una sperimentazione svolta in collaborazione con Innovhub SSI ed Eni S.p.A. Quattro innovative miscele di benzina sono state testate su di un’automobile GDI Euro6d-TEMP, in accordo con le recenti procedure di omologazione in laboratorio (WLTP, Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) e in strada (RDE, Real Driving Emissions). La composizione delle miscele è stata pressoché la seguente:
Il fine della sperimentazione è stato la verifica della conformità dell’uso di tali miscele allo standard Euro 6, nonché il confronto fra le tre miscele innovative e la Miscela A di riferimento. L’analisi ha incluso gli inquinanti regolamentati, i gas serra, e una vasta gamma di inquinanti non regolamentati. Nessuna delle miscele ha mostrato alcuna criticità rispetto agli standard, sia in laboratorio che su strada.
Rispetto ai valori misurati in laboratorio, i test su strada sono risultati in un aumento di ossidi di azoto, CO2, e consumo di carburante, e in una diminuzione di monossido di carbonio, idrocarburi incombusti, metano e numero di particelle. Le differenze fra miscele osservate in laboratorio non sono state confermate da quelle osservate su strada, a causa della differente metodologia e dell’intrinseca non ripetibilità dei test RDE su strada. In aggiunta, è stato dimostrato come i dati di emissione risultanti dal processamento dei dati secondo normativa possano differire significativamente dai dati di emissione misurati direttamente allo scarico.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti sui risultati dello studio, si rimanda all’articolo, disponibile gratuitamente per 50 giorni al seguente link.

Martedì 9 marzo 2021 si è svolta con successo la quinta edizione di “Rifiuti e Life Cycle Thinking”, giornata dedicata alla presentazione e discussione di lavori sul tema: “Sviluppi e applicazioni delle metodologie basate sul Life Cycle Thinking nella gestione e trattamento dei rifiuti, a supporto di un’economia sostenibile”.
L’evento si è svolto interamente online e la diretta è stata salvata sui canali social del gruppo di ricerca AWARE
Clicca qui per collegarti al canale Youtube
Clicca qui per collegarti alla pagina Facebook
Clicca qui per visualizzare tutte le presentazioni