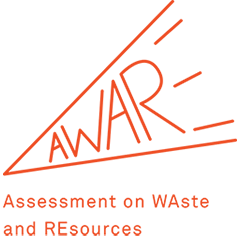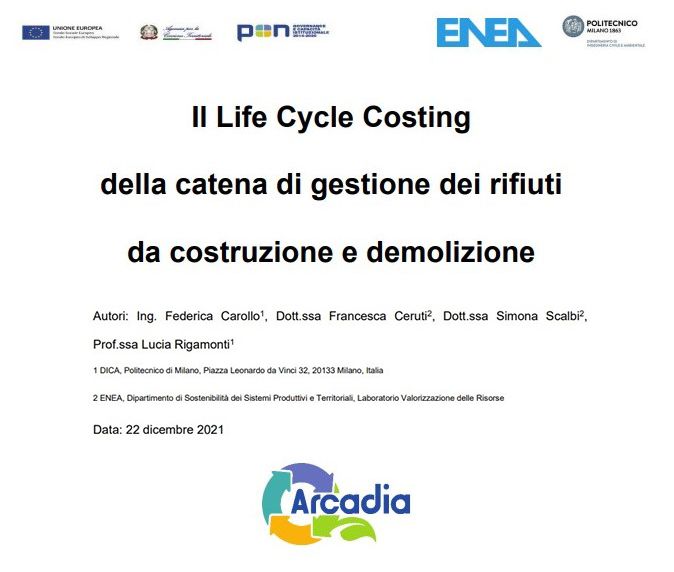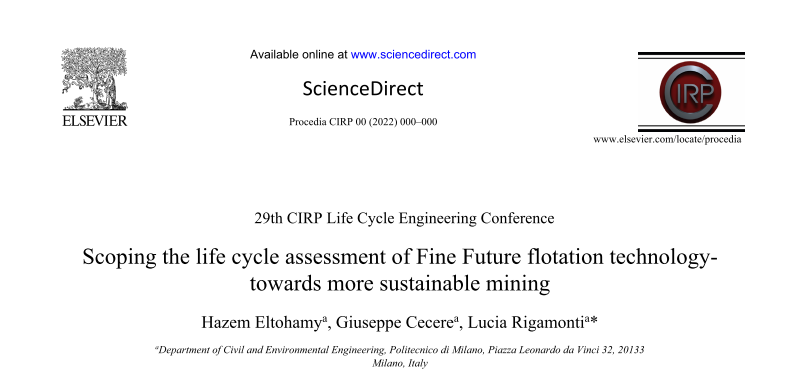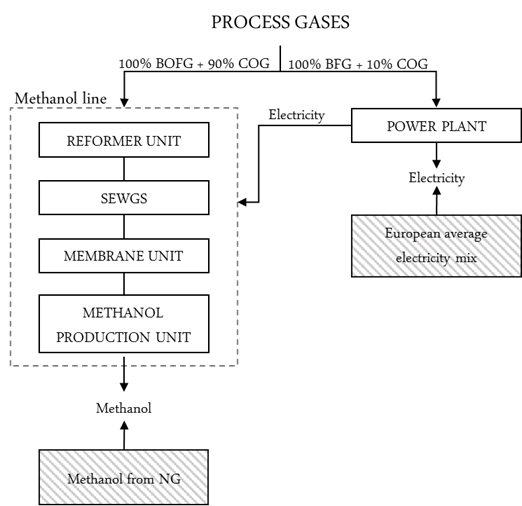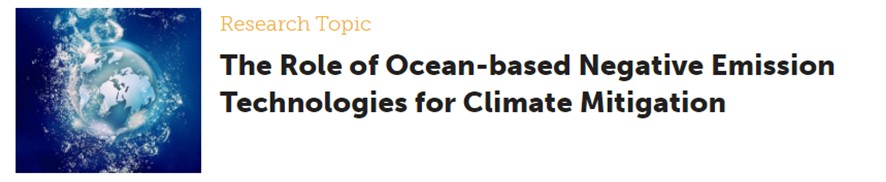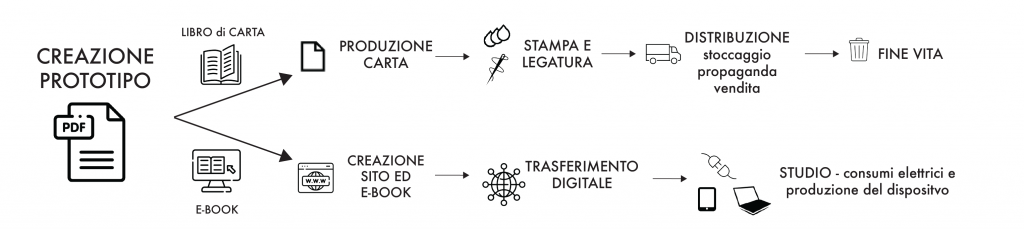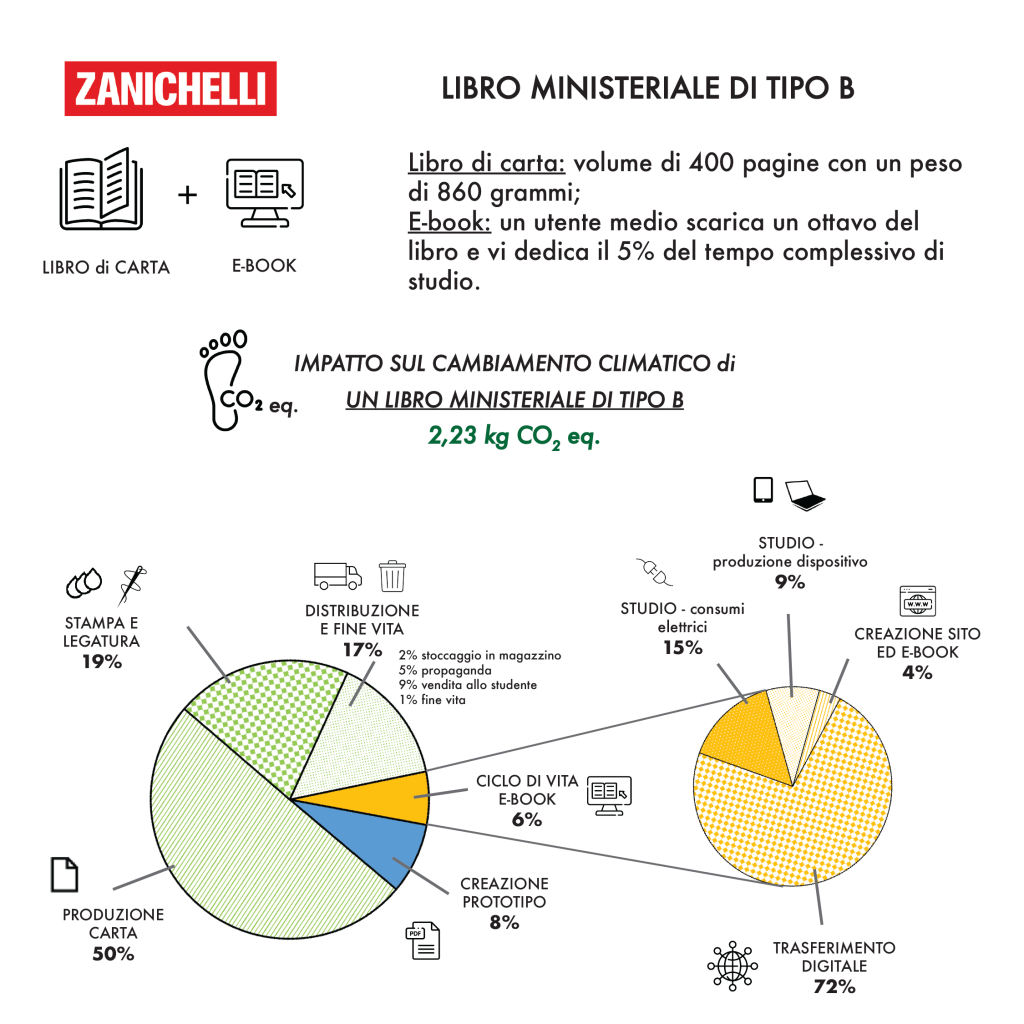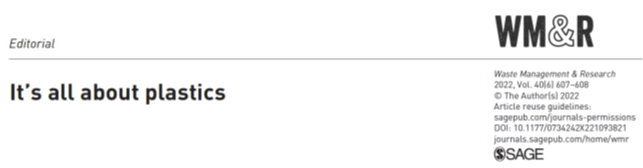
Questo il titolo dell’ultimo editoriale di Mario Grosso su Waste Management & Research, dove si prova a dare un’interpretazione dei sentimenti contrastanti suscitati dal materiale che più di ogni altro accompagna ogni momento della nostra vita. Sentimenti ben riassunti dalle due posizioni seguenti.
Una recente dichiarazione sulla plastica promossa da numerosi scienziati e basata sulla valutazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente sull’inquinamento da plastica. Si legge in particolare che “le attuali pratiche di produzione, progettazione, uso e smaltimento della plastica hanno gravi conseguenze negative per la salute dell’ecosistema, la biodiversità, la salute umana, inclusi fertilità e cancro, il clima, i mezzi di sussistenza sostenibili, la diversità culturale e quindi i diritti umani in tutto il mondo”.
Le affermazioni dell’industria della plastica, che sottolinea il ruolo cruciale di questo materiale nel migliorare la qualità della vita in molti campi diversi. L’ultimo rapporto di Plastics Europe recita: “oggi, la plastica offre numerosi vantaggi alla società. Aiuta a nutrire il mondo in modo sicuro e sostenibile; contribuisce a edifici e case più efficienti dal punto di vista energetico; consente un grande risparmio di carburante in tutti i mezzi di trasporto garantendo il passaggio a una mobilità verde e può persino salvarci la vita”.
L’editoriale è disponibile ad accesso aperto a questo link