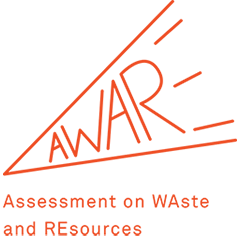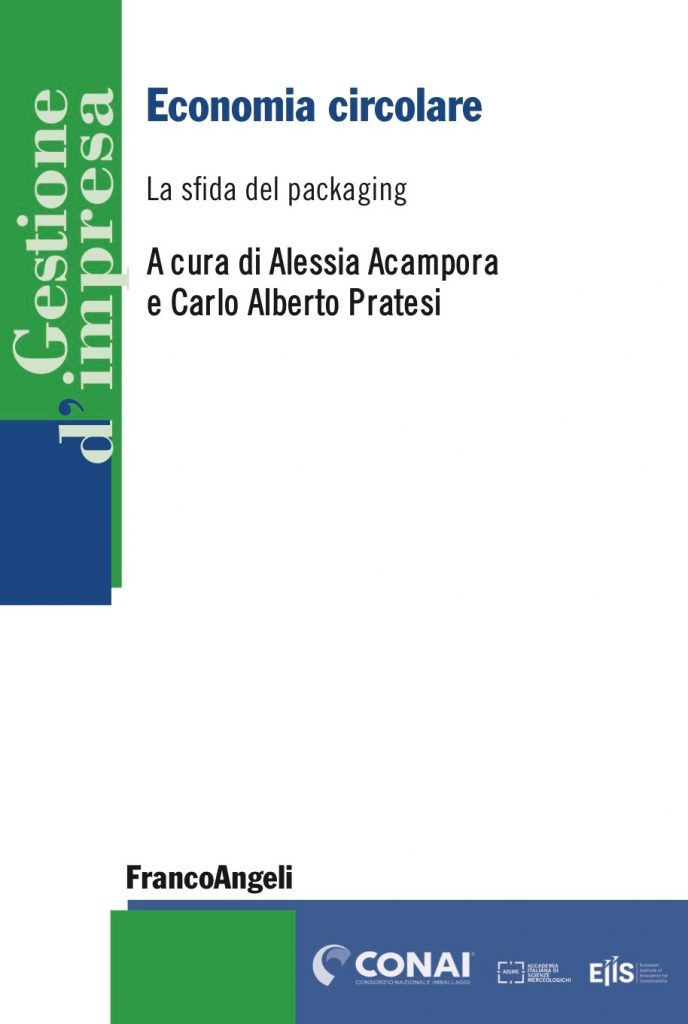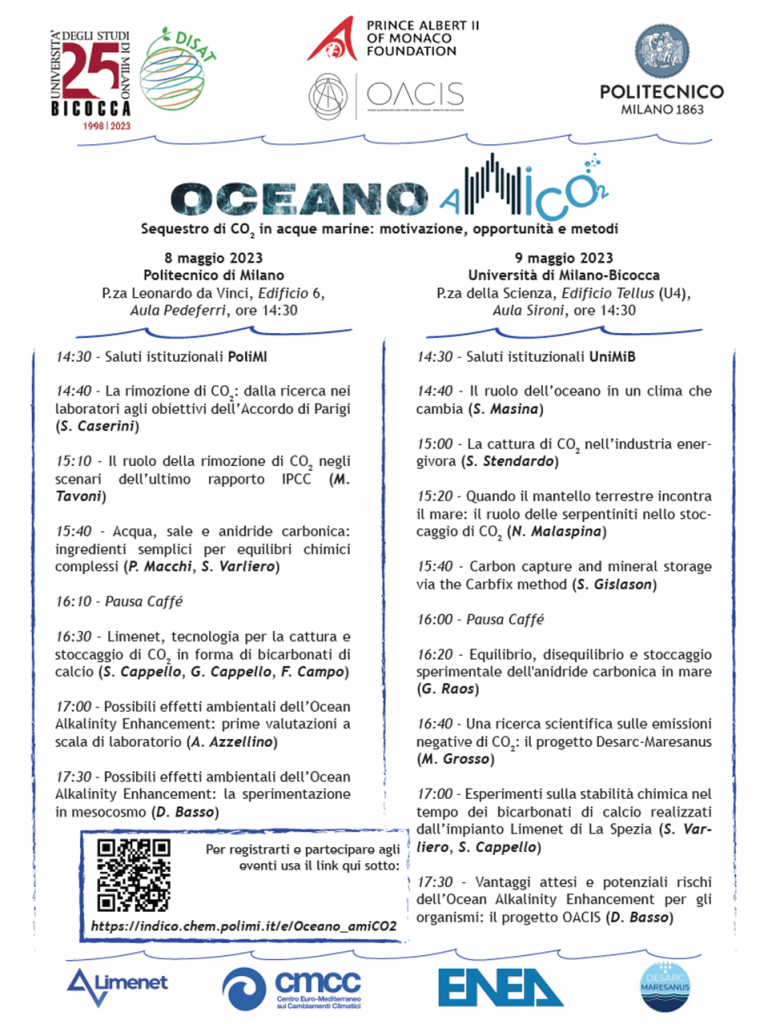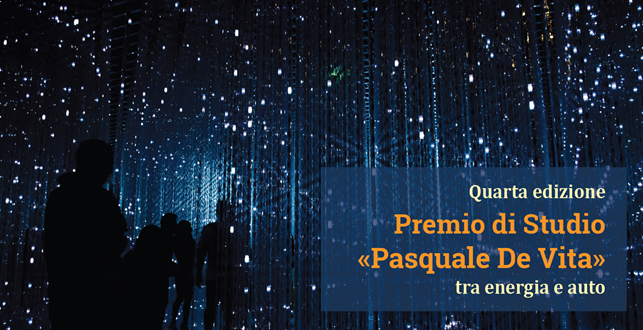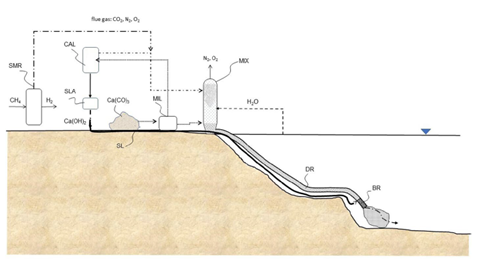Una sessione intensa, quella delle lauree magistrali di maggio 2023!

Lo scopo del mio elaborato è quello di testare e proporre una tecnica che sia in grado di integrare la sfera economica e quella ambientale di un qualsiasi sistema produttivo.
Si è scelto di approfondire tre tipologie diverse di metodi d’integrazione, con il fine di evidenziarne i punti di forza e i limiti principali. Gli strumenti differiscono sia per lo scopo con cui viene condotta la valutazione che per la tipologia dei risultati ottenuti. Si conclude che non è possibile stabilire a priori quale sia la tecnica migliore, poiché la scelta del metodo più adatto è funzione del tipo di problema da risolvere.
Il caso studio proposto nell’elaborato prevede la valutazione della sostenibilità legata alla demolizione selettiva di sette manufatti differenti. L’unica tra le metodologie analizzate in grado di valutare le prestazioni complessive di un sistema è quella dei Metodi Decisionali Multi-Attributo (MDMA). Si è scelto di utilizzare una tecnica in particolare, ovvero quella del Fuzzy Analytical Hierarchy Process & Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (FAHP&TOPSIS). Questa permette sia di includere nell’analisi le preferenze dei decisori coinvolti che di ridurre l’incertezza generata dall’uso di un linguaggio spesso impreciso tramite l’applicazione della teoria degli insiemi fuzzy. Inoltre, è in grado di riassumere le informazioni relative alla dimensione economica e a quella ambientale di un sistema in un unico punteggio.
Paula Barbato

Con gli ultimi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, ci sono nuove opportunità di fare la differenza tramite l’adozione di tecnologie innovative per separare i rifiuti riciclabili all’inizio della catena del valore del rifiuto permettendo di aumentare la qualità della raccolta differenziata. Il cestino WiSort, un prototipo automatico in grado di separare il rifiuto in quattro diverse frazioni (carta, plastica, vetro/alluminio e indifferenziato) è stato installato in un’area pubblica dell’aeroporto di Milano Malpensa con l’obiettivo di studiare l’introduzione di un dispositivo di questo tipo in un contesto dove la raccolta differenziata è più impegnativa per le persone. Nel mio progetto di tesi, oltre ad una sperimentazione sul campo per raccogliere feedback da parte dei passeggeri che hanno usato questo cestino ed analizzare la composizione del rifiuto urbano generato nelle aree pubbliche, è stata svolta un’analisi economica ed ambientale (tramite metodologia LCA) di questo sistema alternativo per la separazione del rifiuto. I risultati mostrano benefici sia economici che ambientali rispetto alla situazione attuale, dove il rifiuto urbano prodotto nelle aree pubbliche viene principalmente inviato a recupero energetico, quando il cestino WiSort viene utilizzato a patto che quest’ultimo abbia un elevato livello di accuratezza di classificazione (superiore all’80%) grazie alla maggiore quantità di materiale effettivamente avviato a recupero o riciclo.
Alessandro Manea

La tesi consiste in un caso di studio di un impianto di digestione anaerobica (DA) di Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU), situato in Puglia, in cui il digestato viene miscelato con rifiuto verde e mandato a post-compostaggio. L’impianto, progettato per operare “a secco”, ovvero con un contenuto di solidi nel digestore di 17%-25%, ha registrato un comportamento semi umido (9%-15% di solidi), con pesante impatto economico sul processo di miscelamento e post-compostaggio. Questo lavoro ne ricerca cause, conseguenze e possibili soluzioni, proponendo configurazioni impiantistiche alternative del trattamento del digestato. I risultati mostrano che il digestore non è dimensionato per lavorare a secco con la qualità del rifiuto organico ricevuto, e che una temporanea sottoalimentazione in fase di avviamento ha favorito una eccessiva liquefazione del substrato. La configurazione con disidratazione del digestato e pastorizzazione del suo separato liquido determina il costo più basso. Per migliorare la profittabilità dell’impianto è fondamentale implementare il ricircolo e minimizzare lo smaltimento di materiale di scarto.
Gianluca Roccasalvo

La scoria primaria da forno elettrico ad arco (EAF) è il principale sottoprodotto derivante dalla produzione di acciaio nelle acciaierie elettriche. Questo materiale può essere potenzialmente sfruttato in diversi campi grazie alle sue proprietà fisiche e meccaniche, che sono paragonabili e, in alcuni casi, addirittura migliori di quelle di materiali naturali come ghiaia e sabbia.
Tuttavia, l’impiego delle scorie EAF è limitato dal potenziale rilascio di composti pericolosi nell’ambiente; infatti, il problema principale è dovuto alla lisciviazione di metalli pesanti.
Nel mio lavoro di tesi, condotto durante il tirocinio presso Lucchini RS, la procedura studiata consisteva nell’immersione completa di scorie EAF raffreddate ad aria in una vasca d’acqua che lavorava con diversi rapporti liquido/solido e tempi di permanenza. Lo scopo di questo studio è stato quello di fornire all’acciaieria un trattamento ottimizzato delle scorie a umido, consentendo il recupero del materiale come sottoprodotto.
I risultati mostrano che l’aumento alternato del rapporto liquido-solido o del tempo di residenza migliora il comportamento a lisciviazione del materiale trattato. Infine uno studio LCA preliminare ha dimostrato il beneficio ambientale legato alla sostituzione della scoria al posto dell’aggregato naturale, nell’ambito della fabbricazione di calcestruzzo.
Luca Testini

Nowadays, most of us understand the importance of the environment and its link to the economy and industry. The construction industry as one of the biggest industries in each country has a big
impact on SD. Improvement of this industry is because of population growth, and migration from the country to the town which plays a significant role in the economic growth of the state’s GDP (Gross Domestic Product). This industry provides urgent socio-economic infrastructure such as roads, hospitals, schools, and other basic which directly affect the quality of citizen’s life.
On the other hand, it has major effects on environmental degradation and is one of
the biggest industries in using natural resources. Rising greenhouse gases emission, global warming, ozone layer depletion, and decreasing biodiversity are the most important consequences of the unbalanced use of natural resources. Consequently, use of the materials with lower embodied energy instead of fossil-based materials has a significant role in reducing the environmental impacts of building projects. One of the optimal solutions to minimize the environmental impacts concerning the LCA methodology which is the best way to assess the building in its whole life cycle is expanding the bio-based industry with the goal of a low-carbon industry with circular material flows. Among different types of construction materials, insulation is one of the most effective ones to help improve the building’s energy behavior and indoor environmental quality. Cellulosic Fiber insulations as one of the natural-based
insulations have a significant role in waste reduction and decreasing our demand for
natural resources that are strongly involved in global climate change.
Shadi Hamidkhani