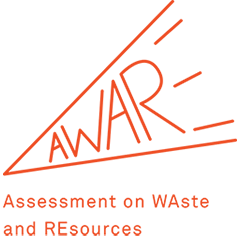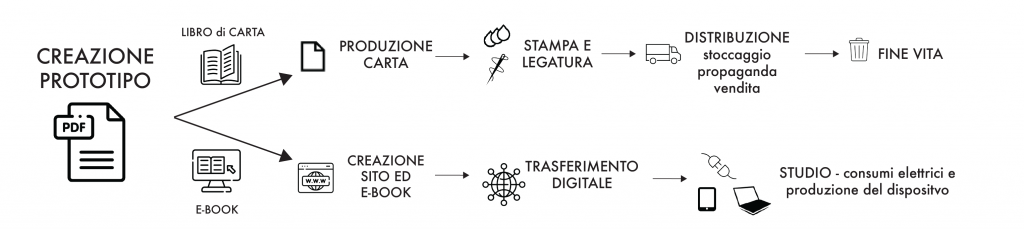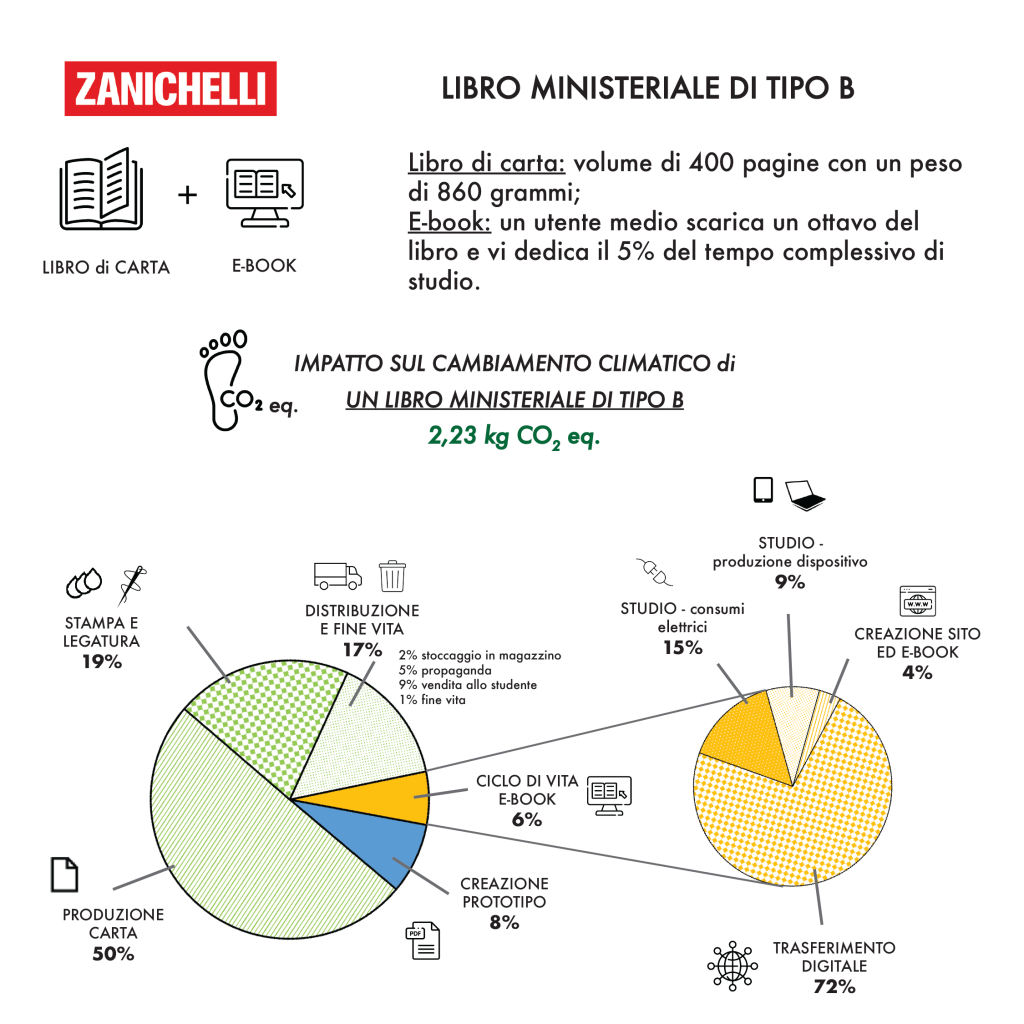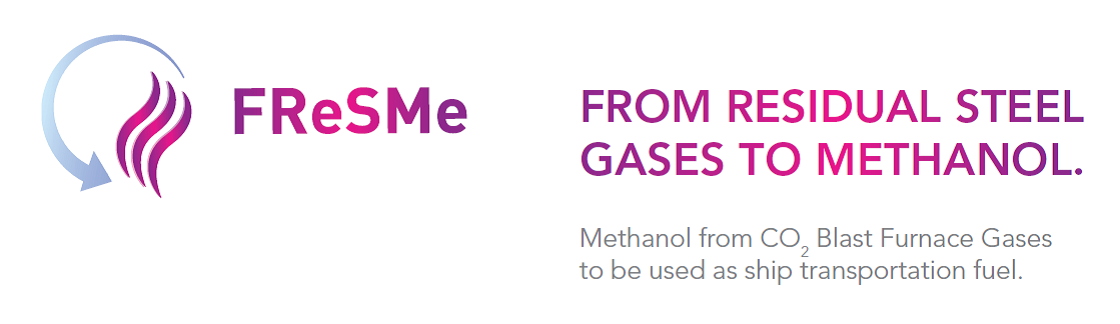E’ ora disponibile il Libro bianco SSD – Smart Sustainable Districts, sviluppato nell’ambito di un progetto promosso dal Politecnico di Milano e coordinato dal Consorzio Poliedra, con l’obiettivo di individuare e suggerire orientamenti, azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica, e il rafforzamento della resilienza dei sistemi territoriali e sociali attuabili alla scala locale.
Il progetto ha visto il coinvolgimento di più di 100 ricercatori di vari dipartimenti dell’Ateneo e dei suoi Consorzi (il Sistema Polimi) con competenze tecnico-scientifiche ma anche umanistico-sociali, che a partire dalle criticità degli attuali ambienti urbani, impietosamente messe in luce dalla pandemia, e dagli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, dal Green Deal e dal piano NextGenerationEU, hanno messo a fuoco il concetto SSD – Smart Sustainable Districts – per definire linee guida pratiche per affrontare la transizione ecologica a livello locale e orientare le necessarie trasformazioni urbane ed i processi di rigenerazione urbana, in chiave smart e sostenibile.
• smart sta a sottolineare l’adozione di approcci “intelligenti”, multidisciplinari, innovativi e flessibili, che sfruttino al meglio le risorse e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie.
• sostenibile, perché permetta di bilanciare le tre dimensioni ambientale, sociale ed economica, contribuendo a raggiungere e mantenere un’elevata qualità della vita, della salute e del benessere dell’ambiente e della comunità, la conservazione delle risorse naturali e, allo stesso tempo, creare opportunità sociali ed equità per le persone.
Il lavoro affronta aspetti tecnico-scientifici ma anche umanistici e sociali, quali l’inclusione e integrazione sociale, la qualità dell’ambiente e del paesaggio, degli spazi pubblici e privati, la mobilità e l’energia, le economie locali e i modelli di business, la gestione e utilizzo dei dati con un approccio multidisciplinare che vede nell’integrazione e nel coordinamento sui vari temi il fattore chiave per guidare l’attuazione dei processi di trasformazione e rigenerazione urbana realmente smart e sostenibili e capaci di attivare sinergie e produrre effetti positivi cumulati. La dimensione locale investigata è inoltre quella che offre le migliori possibilità di attuazione, gestione amministrativa e monitoraggio delle azioni e dei loro effetti e pertanto contribuisce a rendere lo studio e le soluzioni proposte molto concrete.
Per AWARE ha contribuito al libro bianco Mario Grosso, insieme a Elena Sezenna del DICA, autrice di questo post.