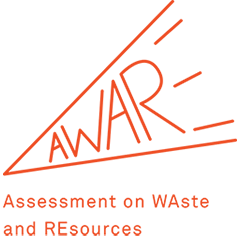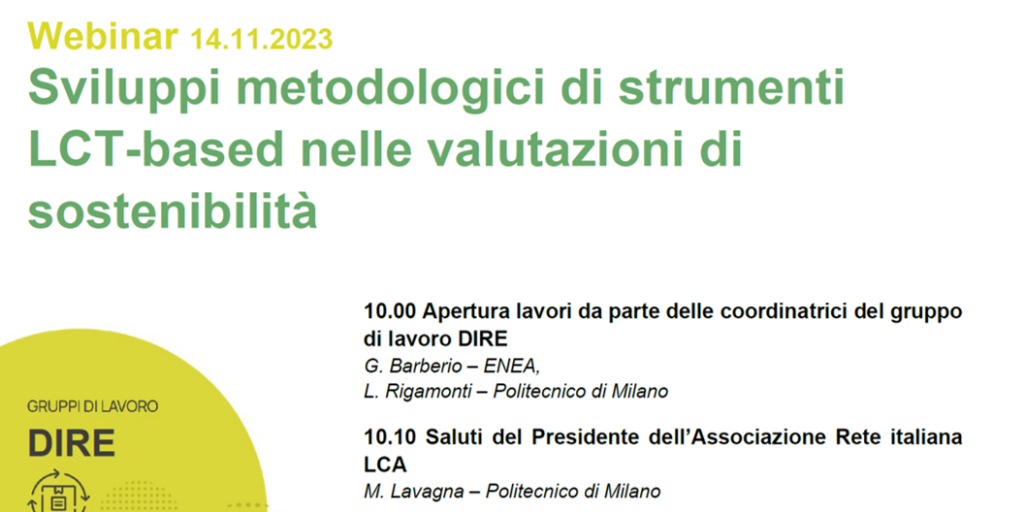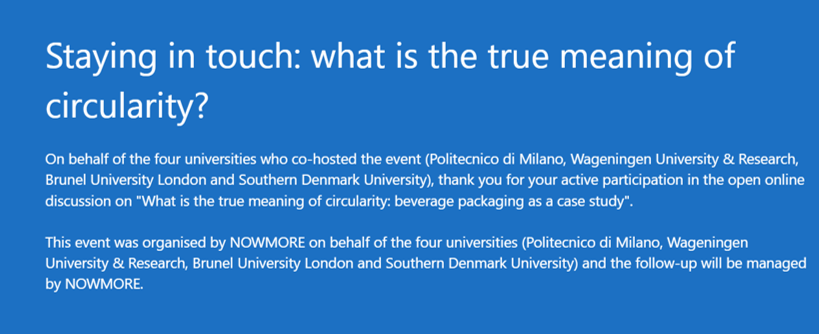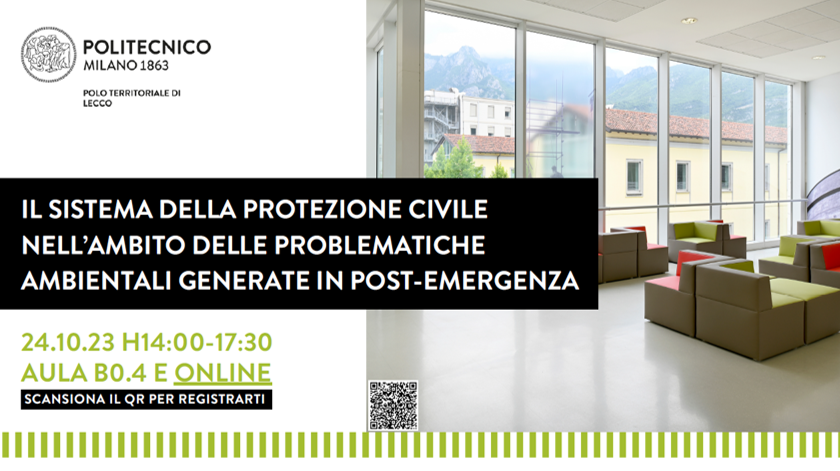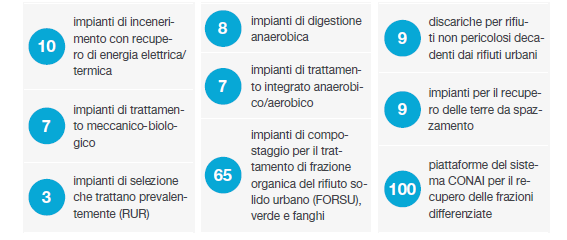Yes-Europe Italy organizza una visita al termovalorizzatore Silla 2 di Milano il giorno Sabato 2 marzo 2024.
Il Gruppo AWARE parteciperà con un intervento del Professor Mario Grosso per discutere delle potenzialità collegate agli impianti di termovalorizzazione e di come gestire correttamente tali impianti per minimizzarne gli impatti ambientali.
Sarà inoltre indagata la percezione del rischio sociale per questo tipo di impianti, tramite un questionario predisposto da Giuseppe Cecere. Lo scopo sarà quello di identificare i temi maggiormente sentiti per discutere di quali possano essere le misure più adeguate per ridurne i rischi connessi.
Qui il comunicato di Yes Europe-Italy:
Partecipa alla visita al termovalorizzatore di Silla 2, a Milano il Sabato 2 marzo 2024. Sarà un’opportunità unica per scoprire il funzionamento di un vero termovalorizzatore e imparare come contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.
Unisciti a noi per una giornata divertente e informativa, dove potrai partecipare a visite guidate, ascoltare interessanti start-up innovative e partecipare a un workshop interattivo a gruppi. Avrai la possibilità di incontrare esperti del settore e porre loro tutte le tue domande sul trattamento dei rifiuti.
Parteciranno all’evento
-WiSort start-up innovativa che sviluppa soluzioni hardware e software hightech per migliorare la qualità dei rifiuti e ottimizzare la user-experience per una raccolta differenziata più sostenibile.
-M.Grosso Professore associato e docente di Solid waste managment and treatment presso il Politecnico di Milano.
La partecipazione all’evento è completamente gratuita e include il servizio navetta da e per Milano Centrale, un pranzo fornito da un catering e una visita guidata all’impianto. Non ci sono costi nascosti o aggiuntivi per i partecipanti, tutti questi servizi sono offerti gratuitamente per garantire un’esperienza indimenticabile.
Non perdere questa occasione per imparare e divertirti allo stesso tempo! Ti aspettiamo al termovalorizzatore di Silla 2 per una giornata indimenticabile. Prenota subito il tuo posto!
Per partecipare, qui il link di iscrizione!